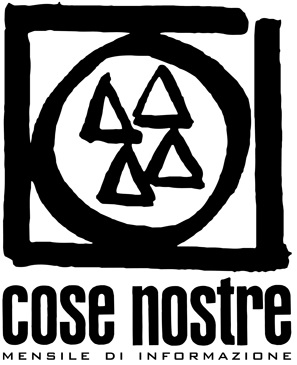Quando sentiamo parlare di tenuta “La Mandria” il nostro pensiero ci porta subito a identificarla al Parco di Venaria con il suo imponente castello reale, ma in realtà quella di Venaria Reale non è la sola antica tenuta dei Savoia che veniva chiamata con questo nome.
Questo perché il nome deriva dalla funzione per cui nacquero questi complessi, cioè l’allevamento in grande quantità di cavalli che servivano in abbondanza ai Savoia.
Infatti l’allevamento dei cavalli costituiva un’esigenza fondamentale non solo per la caccia, ma anche e soprattutto per la guerra e per il trasporto.
Come tutti sanno, prima dell’invenzione del motore, il cavallo fu per secoli di fondamentale importanza all’economia umana, come mezzo principale di trasporto per le merci, per il lavoro nei campi, per le comunicazioni veloci, per la posta e, non ultimo, per la cavalleria dell’esercito.
Per questi motivi è ovvio che anche per i Savoia, già a partire dalla fine del XVI secolo, fosse importantissimo e strategico allevare e possedere direttamente, senza dipendere da altri, un continuo approvvigionamento di cavalli, forti e sani per la caccia e la guerra.
Per questo fu indispensabile per i Duchi sabaudi realizzare degli appositi allevamenti intensivi che continuamente potessero fornire numerosi cavalli appositamente addestrati; allevamenti che necessitavano di ampi spazi per i pascoli e l’addestramento, e di imponenti fabbricati appositamente studiati per l’allevamento, dove tutto era rigorosamente gestito e organizzato sotto ogni aspetto per ottimizzare i risultati: delle vere e proprie “fabbriche di cavalli”.
Alla metà del Settecento con la Mandria della Venaria Reale come polo centrale, si venne a costituire un grande sistema territoriale di allevamenti su scala regionale, suddiviso fra la tenuta delle Apertole (vicino a Livorno Ferraris) e i pascoli di Santhià, le tenute di Desana e di Chivasso, dove i cavalli soggiornavano nei diversi periodi dell’anno.
La Mandria di Chivasso
Nell’ottica di aumentare e razionalizzare la produzione di cavalli venne deciso, a metà del Settecento, di realizzare una nuova tenuta specializzata per l’allevamento di cavalli di razza e in particolare per l’allevamento di cavalle e puledre nella zona di Chivasso, il tutto direttamente dipendente, come organizzazione, dall’azienda economica di Venaria Reale.
I Savoia, per far fronte alle difficoltà legate all’allevamento, decisero di costruire una struttura completamente nuova su basi “moderne”, traendo ispirazione sia dall’Haras National du Pin (complesso francese, realizzato nel 1715 e soprannominato la Versailles del cavallo), sia da altre tenute già operative in Europa.
La nuova Mandria venne realizzata molto velocemente nel decennio che va dal 1760 al 1770, sia per quanto riguarda gli edifici, sia per quanto riguarda la struttura economica, amministrativa e territoriale.
Completati gli acquisti dei terreni, circa 767 ettari nella zona tra Chivasso, Mazzè, Rondissone e Verolengo, i lavori per la costruzione di “una nuova fabbrica” al centro del possedimento, partirono nel 1763 su progetto dell’architetto misuratore Giuseppe Giacinto Bays (nativo di Candelo e morto a Torino nel 1776, collaboratore di Benedetto Alfieri).
Il sistema di cascine
La posizione scelta per la tenuta e i territori agricoli ad essa collegati, a circa 8 km dal centro di Chivasso, risultava favorita dal vicino torrente Orco, dal quale si potevano derivare le grandi quantità d’acqua necessarie, tramite il prolungamento del canale di Caluso.
Tale estensione includeva, oltre all’edificio monumentale centrale della Mandria destinato all’allevamento dei cavalli, una serie di cascine per la coltivazione dei terreni, le quali avevano inizialmente anche la funzione di ospitare personale e attrezzature in via provvisoria, fino a che non fosse stata completata la costruzione principale.
Queste strutture agricole erano la Cascina Bisognosa (demolita nel 1802), la Cascina Nuova del Tuono, la Cascina Violina, la Cascina Rapella, la Cascina Giletta, la Cascina Isola (demolita ad inizio ‘800), e la Cascina Bonauda.
All’inizio, nel 1767, l’Azienda Economica di Venaria concedette in affitto la tenuta della Mandria a Giovanni Battista Valle, ma questo tipo di gestione si rivelò una soluzione antieconomica e dopo solo otto anni si tornò alla gestione diretta.
I terreni erano suddivisi in “lame”, in modo che i cavalli potessero passare da un terreno all’altro solo dopo aver consumato l’erba in modo regolare, al fine di permettere una rotazione continua che permetteva la ricrescita continua dell’erba.
Il complesso monumentale
Il complesso centrale degli edifici, progettato dall’architetto Bays secondo criteri di estrema funzionalità, venne strutturato secondo uno schema rettangolare a tre corti e posto in posizione baricentrica rispetto ai terreni circostanti, attraversati da due viali alberati intersecantesi nella corte centrale, con quattro porte di accesso poste al centro dei lati esterni in corrispondenza dei viali.
I cortili a nord e sud, a due piani, di forma rettangolare, erano destinate a corti di servizio, circondate da bassi fabbricati a manica semplice utilizzate principalmente a deposito di fieno e ricovero degli attrezzi.
Il cortile centrale, vera e propria “corte d’onore” con funzione di rappresentanza, vede ancora oggi ad est e a ovest due maniche più grandi simmetriche tra loro, con il fronte che, rivolto verso il piazzale dell’abbeveratoio, risulta avanzare nella porzione centrale rispetto al resto della manica. In corrispondenza di tale avanzamento di volume l’edificio è attraversato dal grande passaggio carraio affiancato da due passaggi pedonali, a guisa di piccola galleria.
Il fabbricato di levante fu il primo ad essere realizzato, tra il 1764 e il 1765, mentre quello di ponente venne terminato nel 1766 insieme al campanile, ed entrambi erano destinati ad ospitare le dimore e gli uffici del personale dirigente.
Le scuderie
La grande corte è chiusa a nord e sud da lunghe maniche che ospitano le stalle degli equini collocate sotto ordinate e magnifiche sequenze di archi; in quel tempo erano numerose, per poter suddividere i cavalli in base a razza, sesso e caratteristiche dell’animale.
Le scuderie sono caratterizzate da uno spazio rettilineo con quattro porte d’accesso, dalle quali si può passare al vano scala, e portano al piano superiore o alla cantina.
Gli ambienti sono voltati, con un’unica volta a botte lunettata, e poggiano su una doppia fila di colonne che in tal modo divide lo spazio in tre settori: un corridoio centrale, e due spazi laterali per l’alloggio dei cavalli.
Al piano superiore erano collocati fienili o magazzini per il foraggio, con aperture comunicanti con il piano sottostante per facilitarne la distribuzione agli animali.
Al centro della grande corte si trovava un grande abbeveratoio circolare per i cavalli (del diametro di 17,5 metri circa ed altezza di 1,54 metri), che purtroppo venne demolito nel 1952 e sostituito con un piccolo pozzo.
Esternamente tutto il complesso si presenta con una facciata in mattoni pieni lasciati a vista, mentre gli interni si presentano caratterizzati da volte a botte, a vela, a crociera, soffitti a cassettoni in legno, pavimenti in cotto, decorazioni sulle porte in legno, o ancora colonne in pietra e camini in marmo.
La chiesa parrocchiale, dove ancora oggi si celebrano le funzioni religiose, presenta una architettura esterna simile a quella del complesso, che se non fosse per la presenza di una croce sul tetto sopra la porta d’ingresso, non si direbbe che sia una chiesa, mentre l’interno si presenta con una volta decorata da sobri stucchi che rappresentano vasi e bracieri; nel presbiterio campeggia ancor oggi una pala settecentesca raffigurante la Madonna con sant’Eligio vescovo.
Il declino ottocentesco
Con la conquista francese il “tenimento” diventò bene nazionale e concesso in affitto a una società di ex nobili che appoggiavano la Rivoluzione Francese e che impiantarono nella tenuta un vasto allevamento di pecore di razza pregiata.
Con la Restaurazione la Mandria di Chivasso, al pari delle altre Mandrie perse la sua importanza, e seguendo la sorte di Venaria, decadde poco alla volta passando alle dipendenze della Regia Intendenza di Finanza nel 1834, segnando anche il definitivo allontanamento degli interessi dei sovrani dalle Mandrie.
Dopo circa un ventennio, la tenuta chivassese fu messa all’asta nel 1854 ma, andata deserta, ne venne effettuata una seconda l’anno successivo in cui venne acquistata dal conte Apollinare Rocca Saporiti.
Nella primavera del 1859 l’esercito piemontese dispiegò le sue truppe nelle campagne dell’ex tenuta regia per contrastare l’avanzata dell’esercito austriaco.
Il campo d’aviazione
Alla vigilia della prima guerra mondiale nell’ampio terreno pianeggiante venne ospitato un campo d’aviazione e di riparazione di aerei.
Agli albori dell’aeronautica in Italia, con la costruzione dei primi aeroporti, sorsero su tutto il territorio numerosi campi volo secondari con lo scopo di creare una rete di campi di atterraggio di sicurezza per i velivoli, che all’epoca certamente non garantivano lunghe percorrenze, e i guasti erano all’ordine del giorno.
Questi campi sorsero soprattutto lungo le principali rotte aeree, e una di queste era proprio quella che dall’aeroporto di Torino (quello di Mirafiori oggi scomparso) raggiungeva il Friuli passando da Milano.
Questo percorso prevedeva tutta una serie di campi, in modo tale che il pilota al momento del decollo poteva già scorgere il campo successivo, e così via.
Così da Torino si passava sopra il campo di Settimo, poi quello di Chivasso (che inizialmente venne realizzato alla periferia nord di Chivasso), per proseguire verso Saluggia, Bianzè, Viancino e così via fino a Pordenone, in modo che il pilota seguisse con sicurezza la rotta con una successione di tappe virtuali, sempre sicuro di poter atterrare in caso di emergenza.
Durante la prima guerra mondiale questa rotta diventò particolarmente importante per la necessità di trasferire continuamente gli aerei prodotti dalle industrie torinesi al fronte e, sommata alla necessità di avere altri campi per raccogliere e smistare i velivoli, il campo d’atterraggio di Chivasso venne spostato vicino alla Mandria, dove gli ampi spazi pianeggianti permisero di farlo diventare un importante centro di smistamento e riparazione degli aerei.
Alla fine della guerra il campo volo perse questa sua prerogativa e l’aeronautica lo abbandonò gradualmente, finché nell’autunno del 1918 gli hangar vennero trasformati in baracche per ospitare temporaneamente i soldati di nazionalità polacca dell’esercito austroungarico.
Infatti, a seguito di accordi tra il governo italiano e il Comitato Nazionale Polacco di Parigi, fu costituito proprio qui un campo destinato ad accogliere i volontari dell’esercito polacco allora in via di formazione, arruolati tra i prigionieri dell’esercito austro-ungarico.
Il 4 dicembre 1918 il cap. Pasquale Brienza dell’Aeronautica Militare accolse il primo contingente di polacchi, e in due anni la Mandria ospitò circa 22.000 militari, che nel corso del 1919 furono inviati in Francia per poi raggiungere la Polonia, che da poco era tornata indipendente.
A levante della tenuta il piccolo cimitero della Mandria accolse i primi venti militari deceduti dopo l’arrivo in Piemonte e in loro memoria fu posta all’interno del cimitero una lapide commemorativa.
Testimonianze fotografiche della permanenza dei soldati polacchi alla Mandria di Chivasso sono raccolte in un album presente nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.
Storia recente della Mandria
Nel dicembre del 1919 la Tenuta venne lottizzata e acquistata da privati, e solo più recentemente, un quarto dell’intera tenuta è divenuto proprietà del Comune di Chivasso.
La tenuta è rimasta, fino agli anni ’90, in un pessimo stato di conservazione, fino a che, nel 1993, venne fondata “Pro Mandria”, un’associazione socio-culturale apolitica e senza scopo di lucro, volta a recuperare e rivalorizzare la Mandria e il suo territorio circostante, organizzando numerosi incontri, convegni, iniziative ed eventi di vario tipo.
Dal 1995 la tenuta è stata inserita all’interno del progetto promosso dalla Regione Piemonte “Corona di delizie Sabaude” e nel 1997 è stata anche dichiarata “Patrimonio dell’umanità”, e sottoposta a vincolo.
Da allora la Mandria ha visto una continua serie di lavori di riqualificazione, tuttora in corso, e ancora oggi, dopo oltre duecento anni, nel terzo weekend di maggio, viene festeggiata la festa di sant’Eligio, protettore dell’antico “tenimento”.
LE ALTRE MANDRIE
La Mandria di Santhià faceva parte anch’essa dell’Azienda Economica della Venaria Reale, e fu una delle sedi transitorie per i cavalli reali di casa Savoia.
Un primo insediamento della Mandria risalirebbe alla prima metà del Settecento, e fu voluto dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia per l’allevamento ed il ricovero dei cavalli nelle pianure del Vercellese.
La costruzione della cascina risale al 1741, su progetto anch’esso dell’architetto misuratore Bays, e si tratta di uno dei più importanti complessi agricoli della zona, collocato lungo la vecchia strada che collegava Santhià a Cavaglià e di lì a Ivrea.
Dell’originaria struttura rimane solo il perimetro esterno che racchiude la grande corte (due padiglioni chiudono a ovest e ad est il perimetro del cascinale). La facciata settecentesca in mattoni rossi del padiglione è ancora caratteristica ed elegante nelle sue forme.
La Mandria di Castell’Apertole a Livorno Ferraris, insieme a quella di Santhià, fu utilizzata dai Savoia come tappa predisposta per gli spostamenti dei cavalli sabaudi, dove giungevano in primavera, prima di spostarsi sui pascoli montuosi del Biellese.
Nel Settecento i Savoia adibirono parte degli edifici, tra cui il fabbricato del castello, a residenza di caccia, mentre altre parti vennero utilizzate per l’allevamento dei cavalli e dei cani da caccia.
La Mandria di Desana (Vercelli) detta “Le Venerie”, fu una delle tenute temporanee per i cavalli da guerra e da caccia dei Savoia, e oggi ospita una società agricola dedita alla produzione di riso.