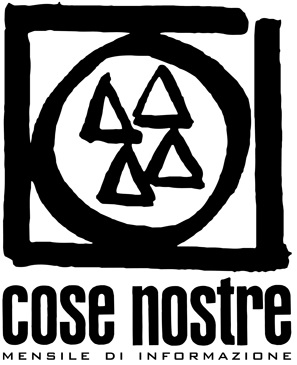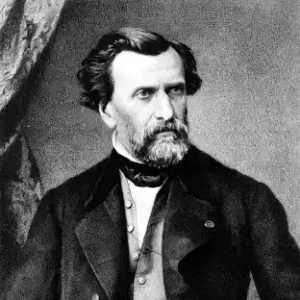 Prossimamente il Teatro Regio ci farà un regalo prezioso: l’esecuzione dell’opera “Hamlet” di Ambroise Thomas. L’ho ascoltata parecchie volte, ma sulle scene l’ho vista una volta sola, nel 2001, sempre al Regio. Opera bella e lodevole… salvo per un piccolo dettaglio.
Prossimamente il Teatro Regio ci farà un regalo prezioso: l’esecuzione dell’opera “Hamlet” di Ambroise Thomas. L’ho ascoltata parecchie volte, ma sulle scene l’ho vista una volta sola, nel 2001, sempre al Regio. Opera bella e lodevole… salvo per un piccolo dettaglio.
Ditemi: potete immaginarvi una cosa più pazza di un Amleto che finisce bene? Eppure è proprio questo che scientemente decise di fare Thomas con l’ausilio dei librettisti Carré e Barbier. Essi intrapresero la paziente ricostruzione d’un libretto basato per il 60% sul testo shakespeariano, per poi all’ultimo (si erano stufati? avevano scoperto che i cinque atti erano già troppo lunghi?) optare verso il lieto fine…
In proposito mi viene in mente quanto disse Verdi (che pure stimava Thomas) in un’intervista rilasciata a Étienne Desgrandes, parole che condivido in pieno: “Quando si tratta Shakespeare non bisogna aver paura, come si dice in Francia, di prendere il toro per le corna!” Questo coraggio mancò al compositore di Metz, il quale aveva da poco raccolto un suo primo vero successo con la deliziosa “Mignon” e pensava di battere il ferro mentr’era caldo con questo “Hamlet”, senza tener conto della propria attitudine naturale indirizzata più al melodico che al drammatico. Fu per smussare i toni del dramma che venne scelto il lieto fine? Forse no, visto che l’impalcatura originale della tragedia era già stata edulcorata e corretta, oltre che temperata da un vento di romanticismo del tutto avulso dall’ottica shakespeariana; che molti dettagli capitali erano già stati falsati, niente uccisione di Polonio, la regina è complice del delitto, l’amore per Ofelia è sommamente enfatizzato, continue ricomparse dello Spettro, nessun duello finale con Laerte… peccati, tuttavia, veniali, e quasi d’obbligo in un libretto d’opera. Invece passare dalla scena del Cimitero allo scontato, improvviso assassinio di Claudio, con tutto quel coro che inneggia felice al nuovo Re di Danimarca, questo è davvero troppo, è come obliterare tutto ciò che era stato costruito in precedenza.
Che non era poco. Infatti il grand-opéra “Hamlet” fu dato nel 1868, esattamente un anno dopo il grand-opéra “Don Carlos” di Verdi, e mi piace pensare che ne abbia assorbito un po’ della pensosa e irrequieta grandezza. La vena di Thomas qui si è concentrata, iscurita, riempita di pause e di silenzi: ci sarà anche mollezza e languore, ma non si può negare la sostanziale nobiltà di intenti e il vigore drammatico di certi momenti. L’orchestrazione è quella di “uno che sa”. Mai banale, sostiene l’azione e la amplifica con stralci strumentali di valore: la scena del teatro nel teatro (si tratta di una pantomima quanto mai opportuna in quella circostanza) viene annunciata da un favoloso assolo di sassofono che crea un’atmosfera nuova, inquietante. Non si può negare che il compositore abbia saputo cogliere l’atmosfera da eterno crepuscolo sia della vicenda che del personaggio, il quale, sempre in scena, benché sia ridimensionato dalla mancanza degli aspetti bizzarri e mattoidi di cui Shakespeare lo aveva gratificato, offre ai celeberrimi momenti di autoindagine la voce calda e matura di un baritono (non, come ci si aspetterebbe per motivi anagrafici, di un tenore). L’altro grande polo della partitura è il personaggio di Ofelia, affidata a un soprano di coloratura di dolorosa e gorgheggiante leggiadria. Ci troviamo di fronte ad un’ennesima “scena della pazzia” che occupa tutt’intero il IV Atto e che non è seconda alle molte altre pur insigni: la mente sconvolta di Ofelia vagheggia frasi assurde, parole volanti (sono forse quelle “words words words” citate da Amleto)… e dal Regno delle Parole, di cui il bardo di Stratford-upon-Avon era sovrano assoluto, si passa direttamente al Regno delle Note, che scopriamo essere leggere ma lancinanti come coltelli.
Ambroise Thomas (1811-1896), della stessa generazione di Verdi e Wagner, fu, dopo Charles Gounod, il più autorevole compositore in campo operistico del Secondo Impero. Elegante, garbato, di bella presenza, ebbe un certo successo salottiero, ma benché fosse un abile pianista non volle mai intraprendere la carriera concertistica. Nel gran secolo degli uomini barbuti, quando se non avevi l’ “onor del mento” ti ritrovavi proprio senza onore (in tante fotografie quasi lo si prenderebbe per una controfigura di Giuseppe Verdi), seppe difendere un proprio aplomb di sicura presa morale. Scrisse molto, ma ai posteri passarono solamente “Mignon” e “Hamlet”, anche se penso che qualche repêchage farebbe bene sia a lui che a noi. Ebbe una carriera accademica di tutto rispetto al Conservatorio di Parigi, prima come apprezzato insegnante di composizione e poi (1871) come direttore di quella mitica istituzione.
L’esecuzione torinese riesuma la possibilità (prevista dallo stesso Thomas ma poi scartata per opportunità esecutive) di far cantare il protagonista nel registro di tenore. Sarà davvero interessante verificare se questo cambiamento vocale aggiungerà qualcosa di nuovo e di più shakespeariano al personaggio.
Al Regio, un Amleto…alla francese
- Advertisment -
METEO
Comune di Caselle Torinese
cielo sereno
12.6
°
C
14.8
°
11.4
°
69 %
2.1kmh
0 %
Gio
24
°
Ven
24
°
Sab
24
°
Dom
16
°
Lun
18
°
ULTIMI ARTICOLI
Una spremuta di… Stivali di gomma!
Siamo nel 1983, nel parcheggio del centro commerciale Westfield Paramatta di Sydney, in Australia.
La folla si accalca nel piazzale, ma non per i saldi....