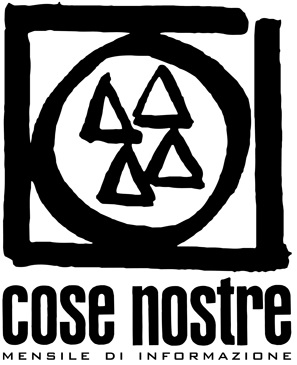È risaputo che esistono le parole… sfigate.
È risaputo che esistono le parole… sfigate.
Sì, quei termini, quei nomi che a prescindere assumono un significato ostile, un’accezione negativa.
Pensate ad animali come l’avvoltoio o il pipistrello, cose o realtà come la spazzatura e la burocrazia… oppure condizioni e stati d’animo come critica e solitudine.
Poveri pipistrelli, così utili e così bistrattati al punto di essere associati al male diabolico; derelitta burocrazia, essenziale per la gestione delle complessità sociali, e sempre unita a disorganizzazione e menefreghismo. Se poi sei un criticone non puoi certo essere valorizzato come persona propositiva e costruttiva…
Già, triste destino per i “dannati” della lingua italiana…
Oggi, poi, in questa nostra frenetica e ipertecnologica società alcuni termini sono letteralmente banditi. Non ci credete? Beh, provate a pensare… oddio, ma non ditelo a nessuno… alla parola Noia.
Sì, proprio la Noia, quel “senso di insoddisfazione, di fastidio, di tristezza, che proviene o dalla mancanza di attività e dall’ozio o dal sentirsi occupato in cosa monotona, contraria alla propria inclinazione, tale da apparire inutile e vana…” come si legge sul dizionario Treccani.
Quella Noia che divenne persino titolo del romanzo drammatico ed esistenzialista di Moravia, destino crudele della vita vuota e insulsa di Dino, pittore sfaccendato di via Margutta.
Persino un romanzo per screditare la Noia!
Non bastasse, la società attuale sembra rifiutare la Noia, considerandola un’emozione negativa da evitare a tutti i costi.
Viviamo in un mondo iperconnesso, in cui ogni momento libero può essere riempito da contenuti digitali, notifiche, intrattenimento istantaneo e stimoli continui. Il tempo vuoto è spesso visto come tempo sprecato, e la Noia come un segnale di inefficienza o mancanza di produttività.
Però…
Però la realtà sembra volerci mandare segnali ben diversi.
Negli Anni Ottanta del Novecento James R. Flynn osservò come, nel corso degli anni, il valore del quoziente intellettivo della popolazione mondiale fosse aumentato in modo progressivo, con una crescita media di circa tre punti per ogni decennio.
Benché l’intensità di questa variazione fosse diversa da paese a paese, i dati rivelavano comunque variazioni positive, nei risultati conseguiti nei test per la misura del QI, di entità variabile da 5 fino a 25 punti.
Le possibili spiegazioni per l’aumento del QI includono:
migliore alimentazione → Una dieta più equilibrata ha favorito lo sviluppo cerebrale;
istruzione più diffusa → L’accesso all’educazione è migliorato, aumentando le capacità cognitive;
esposizione alla tecnologia e ai media → Il pensiero astratto e la risoluzione di problemi sono stimolati dall’uso della tecnologia e dall’apprendimento visivo;
ambienti più complessi → La società moderna richiede capacità di ragionamento più sviluppate rispetto al passato.
A partire dagli inizi degli Anni 2000, però, i punteggi dei test di intelligenza, delle ragazze e dei ragazzi nati tra fine anni ’70 e inizi anni ’80, smettono di aumentare.
Anzi, ad ogni nuova generazione, il quoziente intellettivo inizia a diminuire (in media di mezzo punto ogni anno).
Questo è stato definito “effetto Flynn inverso”.
Oggi, nel 2025, stiamo continuando a perdere punti e il fenomeno sembra anzi accelerare.
Sono molte le ipotesi su quelle che potrebbero essere le cause di questa riduzione del quoziente intellettivo mondiale:
– la diffusione di cibi ultra-processati e ad alto contenuto di zucchero;
– stili di vita meno attivi e problemi di salute mentale;
– cambiamenti nei metodi didattici che non sempre favoriscono il pensiero critico ed astratto;
– fattori legati a migrazioni e diversità linguistica che possono influire sui risultati dei test standardizzati;
– tassi di fertilità più elevati in gruppi con minore scolarizzazione.
Una causa su tutte, però, sembra giocare un ruolo sempre più importante sull’effetto Flynn inverso, soprattutto a partire dalla decade 2010-2020:
il sovraccarico cognitivo determinato dal consumo compulsivo di contenuti digitali.
In altre parole, lo smartphone, il principale strumento che utilizziamo per consumare contenuti digitali (in media 4 ore al giorno, con picchi di 8-12 ore tra i più giovani) ci sta letteralmente friggendo i neuroni rendendoci più irritabili, più ansiosi, più stupidi.
Questo strumento fa talmente parte della nostra vita che non possiamo più farne a meno.
Possiamo però agire su dei cambiamenti comportamentali che possono aiutarci a riprendere in mano la nostra attenzione, le nostre capacità cognitive e, in ultima analisi, la nostra salute.
Certo, ma come?
– Smettendo di portare il telefono in bagno.
– Mettendolo da parte mentre mangiamo.
– Non controllandolo ogni istante…
– … Concedendoci il lusso di annoiarci!
La nostra mente non è fatta per essere sottoposta ad una stimolazione continua e la Noia conta. È’ lì che nascono le migliori idee.
Nei momenti lenti, nei momenti di vuoto della nostra vita, affanno e stanchezza mentale tendono a svanire lasciando spazio alla creatività, all’introspezione, permettendo alla mente di riposare e riorganizzarsi. In passato, molti filosofi e psicologi hanno sottolineato come la noia possa essere una spinta al cambiamento, un’opportunità per sviluppare nuove idee o trovare soluzioni innovative.
Se l’anima ci fa provare noia è dunque per spingerci a cercare: prima dentro, poi fuori di noi. Spontaneamente, ci accorgeremo che ci sarà una nuova persona da scoprire e da conoscere, un nuovo aspetto dello studio o del lavoro da approfondire, un’idea interessante che sorge dalle nuvole grigie della noia stessa.
La Noia non è quindi solo fastidio e sbadiglio: può essere un trampolino per cambiare qualcosa che ci disturba, regalandoci una possibilità in più di vivere meglio la nostra vita.